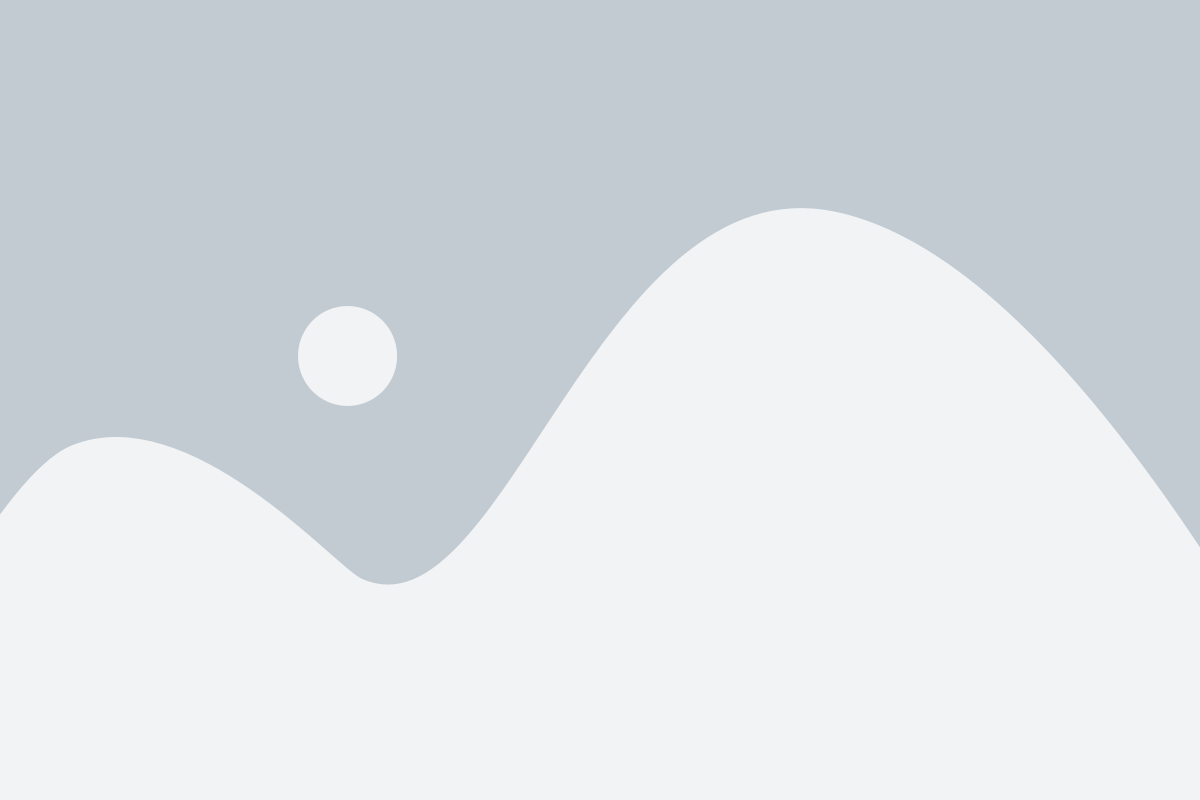L’ordinanza n. 19467/2025 con la quale, la Corte di Cassazione nega al contratto di prossimità ex art. 8, del decreto legge 138/2011 di derogare in peius al minimale contributivo fissato ai fini previdenziali dal contratto collettivo più vicino all’attività effettivamente esercita dall’azienda, offre l’occasione per fare il punto sulle potenzialità e i limiti dello strumento dell’accordo di prossimità.
In primo luogo deve essere osservato che la contrattazione di livello aziendale e territoriale può definire intese derogatorie della legge e dei contratti collettivi (accordi di prossimità) al fine di creare una maggiore occupazione, di incidere sulla qualità dei contratti di lavoro, di promuovere forme di partecipazione dei lavoratori, di sollecitare l’uscita dal lavoro irregolare, di sostenere incrementi di competitività e di salario, di gestire crisi aziendali e occupazionali e di sostenere gli investimenti e l’avvio di nuove attività.
Per le suddette finalità le intese possono riguardare la disciplina degli impianti audiovisivi e delle nuove tecnologie in azienda, le mansioni e l’inquadramento dei lavoratori, le regole in materia di flessibilità del lavoro con particolare riguardo ai contratti a termine, alla somministrazione, all’articolazione dell’orario di lavoro, al regime della solidarietà nei contratti di appalto e ad altre situazioni relative alle modalità di assunzione, disciplina e recesso del rapporto di lavoro.
Il limite invalicabile al quale il contratto di prossimità non si può mai sottrarre è quello del rispetto dei principi costituzionali e del diritto comunitario.
Nell’esercizio della sua funzione di strumento di adattamento della disciplina del lavoro alle specifiche esigenze aziendali il contratto di prossimità deve rispettare alcuni requisiti essenziali: per estendere la sua efficacia a tutti i lavoratori coinvolti la regola fondamentale è che l’accordo sia sostenuto dalla maggioranza dei lavoratori interessati ovvero dalla metà più uno degli stessi (criterio maggioritario assistito da una presunzione relativa di legittimità con conseguente inversione dell’onere della prova in ordine alla sua sussistenza a carico della parte che ne contesta la validità).
Le modalità di verifica della maggioranza varia a seconda della presenza o meno nel contesto aziendale di RSU (rappresentanze sindacali unitarie) e RSA (rappresentanze sindacali aziendali).
In assenza di regole pattizie vincolanti per le federazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie dei Testi unici della rappresentanza (Industria e Commercio), una modalità alternativa di misurazione della maggioranza può essere rappresentata dal referendum aziendale.
Ci si chiede cosa accada qualora l’accordo raggiunto difetti di uno dei requisiti essenziali di cui all’art. 8, del decreto legge 138/2011: l’orientamento giurisprudenziale più recente propende per non considerare l’accordo integralmente nullo bensì per ricondurlo nell’alveo della contrattazione collettiva aziendale di diritto comune, con la conseguenza di renderlo efficace solo nei confronti dei lavoratori iscritti alle sigle sindacali firmatarie dello stesso e di privarlo di quella forza derogatoria delle norme di legge riconosciuta, invece, solo ai contratti di prossimità integralmente rispettosi dei criteri sanciti dall’art. 8, del decreto 138/2011.
Se, come sopra riportato, il requisito del criterio maggioritario è sostenuto da una presunzione di legge iuris tantum (ammessa la prova contraria), per tutti gli altri requisiti legittimanti il contratto di prossimità (rispetto delle finalità, pertinenza delle materie regolate, nesso di causalità tra deroghe di legge e contrattuali e finalità perseguite, mancata lesività di norme di rango costituzionale o e/o comunitario) l’onere della prova, in caso di contestazione, ricade sul datore di lavoro.
E’ bene ricordare come, secondo giurisprudenza consolidata, le deroghe oggetto di un accordo di prossimità debbano essere effettivamente sottoscritte e oggettivamente funzionali al raggiungimento degli scopi dichiarati e corrispondenti al perimetro (finalità e materie) contenuti nella fonte normativa del contratto di prossimità (art. 8, decreto legge 138/2011).
In conclusione, possiamo affermare che il contratto di prossimità rappresenta uno strumento evoluto attraverso cui contemperare esigenze di flessibilità aziendale e tutele dei lavoratori a condizione, indispensabile, che l’accordo evidenzi con la massima trasparenza e specificità le finalità perseguite, le materie oggetto di deroga, la sussistenza del criterio maggioritario di rappresentatività e il rispetto delle norme inderogabili.
Lo Studio resta a disposizione.